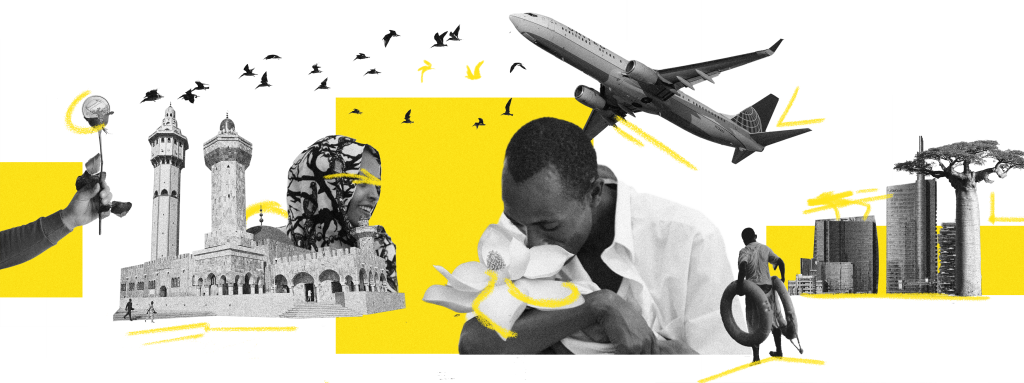Perché non ti trovi un lavoro normale?
Migranti in cerca di lavoro: difficoltà post-accoglienza
È mattina. Sono seduto al bar. Sto facendo colazione. Sono con altre persone.
Ad un tratto, si avvicina un signore, il solito venditore di rose, chiedendoci un euro per una birra.
Una birra.
Alle nove del mattino.
Con un solo euro.
E se ve lo state chiedendo: no, non è una barzelletta.
Logicamente insiste, diventando quasi fastidioso. Mi innervosisco.
Ecco che mi assale una domanda: “ma perché non ti trovi un lavoro normale, anziché rompermi le palle alle nove di mattina, poco prima che inizi un’altra, l’ennesima, giornata di lezioni?”
Ed eccomi qui, che continuo a pensarci. Voglio capirci qualcosa, andare a fondo della questione: mi convinco sia importante comprendere quali difficoltà possa avere un immigrato irregolare nel cercare e poi (forse) trovare un lavoro, partendo dai centri di accoglienza, dal primo istante in cui tocca il suolo italiano, impressionato come Armstrong sulla Luna nel 1969.
Inizio così a riempire il pc di files, dati e statistiche sui migranti, trattandoli come una qualsiasi teoria ingegneristica.
Tra millemila siti web ho trovato anche una formalità, una di quelle cose che a noi precisini piace tanto: la distinzione tra migrante irregolare, richiedente asilo, rifugiato e clandestino. Provo a spiegarla.
Un migrante irregolare è una persona che entra in Italia senza regolare controllo alla frontiera o che è arrivata regolarmente su suolo italiano ma a cui è scaduto il visto (quello che hanno i turisti extracomunitari, con valenza di tre mesi) o il permesso di soggiorno. Dopo aver fatto richiesta di protezione di asilo politico, mentre dunque è in attesa del responso, si parla di richiedente asilo.
È importante sapere che già dal momento in cui ha presentato la richiesta diventa a tutti gli effetti un immigrato regolare.
Quando tale richiesta viene approvata dallo Stato Italiano si parla di rifugiato.
Il termine clandestino non viene in alcun modo definito né dai documenti internazionali né dal Diritto dell’UE: è quindi usato nel gergo popolare per indicare una persona senza permesso di soggiorno.
Ho impiegato dei giorni interi per accorgermi che per parlare delle persone bisogna parlare con le persone.
Ecco che mi sono rivolto a Tamara, che si occupa di HR in Adecco, ad Elena che mi ha consigliato di parlare con il preziosissimo Fiorenzo, responsabile del settore Ospitalità ed Accoglienza dell’associazione “Casa della Carità”. Lui mi ha indicato Stephan e Dieudonné come possibili immigrati da intervistare, le cui storie hanno impreziosito la mia vita. Ringrazio anche Kebe che col sorriso stampato in faccia mi ha raccontato la sua storia, assai difficile e toccante.
Parlare con le persone significa prima di tutto conoscerle. Per conoscerle almeno minimamente credo sia importante farsi raccontare la loro storia: cercherò di condensarla in qualche manciata di righe, ma, se vorrete, potrete trovare le interviste integrali sul sito ufficiale di PoliPo.
Stephan, che da bambino sognava di fare il reporter, parte dal Camerun nel 2012 arrivando in Italia con l’aereo come turista. Qui è ospitato da un suo conoscente presso una residenza universitaria per i primi due mesi: poi viene buttato fuori di casa per problemi legislativi e finisce in un centro di accoglienza a Milano, esperienza che per lui sarà fondamentale. Inizialmente faticherà a trovare lavoro: essendo qualificato come idraulico in Camerun, spera di ottenere un mestiere in quell’ambito senza però riuscirci. È costretto così ad accettare lavori molto più umili. Nonostante un periodo difficile, oggi ce l’ha fatta: è un coordinatore dei servizi presso la Casa della Carità. Gli piace perché “permette di dare supporto agli immigrati: do loro la possibilità che io non ho avuto”.
Dieudonné invece parte dalla Costa d’Avorio, dove ha frequentato il liceo scientifico e poi una scuola di disegno edile, il 20 dicembre 1982 con l’aereo. Farà tappa in Francia, da dove, con un treno, raggiungerà Roma e poi Perugia, dove si iscriverà subito all’università per stranieri, in modo tale da imparare il prima possibile l’italiano. La sua storia, ricca di dettagli, ci insegna l’importanza, enorme, di trovare persone disposte a fare del bene lungo il proprio cammino: oggi è manager dell’IT presso una grande multinazionale.
Kebe parte dal Senegal, dove è diplomato come saldatore, nel 2012. Arriva in Marocco: qui prende un barcone per attraversare lo Stretto di Gibilterra. Rimane due anni in Spagna senza sapere nemmeno una parola di spagnolo, per poi spostarsi in Francia, dove lavora per un anno, fino ad arrivare in Italia, a Firenze, da clandestino. Oggi fa l’addetto alle pulizie per una cooperativa.
Loro saranno i protagonisti di questo articolo: io, soltanto un portavoce.
Oggi la legge 130 del dicembre 2020 regola l’accoglienza degli immigrati irregolari.
Questi vengono portati nei centri di prima accoglienza, vicini ai luoghi degli sbarchi, dove ricevono assistenza sanitaria e vengono identificati. Poi sono smistati in “migranti economici”, che si dovranno recare ad un centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in attesa di essere rimpatriati, e in “migranti richiedenti asilo”. Questi ultimi, assieme ai titolari di protezione, accedono al Sai (sistema di accoglienza e integrazione), gestito principalmente dai Comuni, cioè da organi statali. Questo sistema ha due livelli: il primo è di tipo assistenziale e dedicato ai richiedenti asilo, mentre il secondo offre anche servizi di integrazione e orientamento lavorativo ed è destinato ai titolari di protezione.
Il Sai sostituisce ciò che prima era chiamato Siproimi, che a sua volta rimpiazzava lo Sprar dall’ottobre 2018.
Sistema alternativo a quello statale è il Cas (centro di accoglienza straordinaria). Questo è gestito da enti privati e viene usato quando non vi sono più posti nel Sai. Negli ultimi anni tale tipo di strutture è sempre più utilizzato (data l’emergenza).
Mi sono chiesto come davvero si vivesse nei centri di accoglienza. A tal proposito, il racconto di Stephan mi ha stupito:
“Di certo, non si fa una vita normale: si hanno delle regole precise, anche sugli orari. Ad esempio, bisogna entrare dopo le 17.30 ed uscire entro le 9.00.
Nei centri – aggiunge – si è in 12 persone nella stessa stanza: dormi con 11 sconosciuti, che incontri solo lì la sera. È anche difficile vivere con gli altri: soprattutto nelle grandi realtà, come quella di Milano, si incontrano persone molto differenti tra loro, sia per carattere che per cultura.”
È vero, ci sono regole ferree e forse difficili da comprendere, ma i centri di accoglienza sono davvero utili, in quanto “dei volontari gestiscono dei corsi di italiano e danno una mano a cercare lavoro: a volte ti aiutano a fare il curriculum o ad affrontare un colloquio.”
Per Stephan non si è trattato solo di una fredda struttura in cui soggiornare ed imparare, ma “è stata una scuola di vita: mi ha aperto la mente. Ho imparato il potere della condivisione, ad essere paziente e ad ascoltare gli altri”.
D’altro canto, Kebe ha vissuto una storia con sfumature molto diverse. Per i primi mesi, a Firenze, viveva per strada facendo l’ambulante: “Grazie ad alcuni miei amici, iniziai a comprare delle borse a basso costo al mercato dei cinesi per poi rivenderle al mercato di San Lorenzo. Logicamente bisognava stare attenti a non farsi prendere dalla polizia”.
Ora si potrebbe pensare a Stephan come il “buono” e a Kebe come il “cattivo”, quello che viene in Italia per rubare.
Non bisogna però dimenticare che non si tratta di scelte desiderate ma imposte dalle circostanze.
Le stesse circostanze che li spingono a lasciare a malincuore il proprio paese e la propria famiglia, come spiega Kebe: “Purtroppo molti di noi (senegalesi, ndr) sono costretti ad emigrare: gli accordi economici stipulati dal Governo con la Francia, principalmente, e poi anche con la Gran Bretagna, sottraggono molte risorse al mio Paese. Tutto ciò si riversa poi su noi cittadini, che non abbiamo grandi opportunità lavorative, nonostante il livello di istruzione generale”.
Una volta arrivati in Italia ed essere stati regolarizzati (o meno), i migranti si trovano di fronte altre barriere, quali l’italiano e il permesso di soggiorno.
Mi colpisce come Dieudonné abbia fatto dell’italiano un “cardine” del proprio piano di viaggio: “Tramite l’ambasciata, mi ero già iscritto all’università per stranieri: sapevo che fosse essenziale imparare l’italiano”.
Kebe invece ha fatto esperienza “sul campo”, come si suol dire: “Ho imparato l’italiano mentre facevo l’ambulante a Firenze. Al mercato, mentre vendevamo le borse, se non capivo una parola chiedevo ad un mio amico il significato, lui me lo spiegava, io poi scrivevo la parola e quindi la ripetevo tante volte finché non mi entrava in testa”.
Eppure, nonostante la complessità dell’italiano, secondo Dieudonné “diventa una lingua difficile per gli stranieri che si ghettizzano”, in quanto non sono costretti a fare pratica.
Travalicato il “macigno linguistico”, l’immigrato è costretto a fare i conti con il famigerato permesso di soggiorno.
Si tratta di un documento obbligatorio per i cittadini Extra UE che soggiornano nel Bel paese per oltre 90 giorni, tempo dopo il quale scade il visto turistico.
In molti, tra cui anche Stephan e Dieudonné, sfruttano la validità del visto.
Se ne può fare richiesta anche presso gli uffici postali abilitati, ma a rilasciarlo è la Questura (tranne in casi particolari in cui è competenza della Prefettura, come per il ricongiungimento familiare).
Questo ha una certa durata che dipende dal tipo di permesso rilasciato ed è fondamentale chiedere il rinnovo. Infatti, se la scadenza viene prima della data di fine contratto lavorativo, al momento dell’assunzione il datore di lavoro non può per legge ingaggiare il candidato. Ciò non succede se si è in possesso della ricevuta postale che attesti l’avvenuta richiesta di rinnovo, che deve essere comunque eseguita almeno 60 giorni prima della scadenza.
Inoltre, il permesso di soggiorno ha un costo che varia a seconda del periodo di valenza. Tuttavia alcune categorie di migranti, come richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, sono esentate dal pagamento.
Quando arrivano, i migranti sanno già dell’esistenza del documento, ma viene loro difficile svolgere le pratiche per richiederlo: “non sapevo come ottenerlo – spiega Stephan – e recarmi in un centro di accoglienza mi permise di essere aiutato e guidato da volontari, educatori ed avvocati”.
Si tratta dunque della solita burocrazia “all’italiana”, complessa e limitante. Per questo ho chiesto a Dieudonné cosa pensasse riguardo ad un’eventuale abolizione. La sua risposta mi ha spiazzato: “È un documento necessario per differenziare chi è straniero e chi è italiano. Non credo sia giusto rimuoverlo, ma va studiato meglio (…) deve permettere di lavorare: se uno ha famiglia, come fa?” E, riguardo alla possibilità di generare lavoro in nero, aggiunge: “Sicuramente sì perché chi non ce l’ha, necessita comunque di mangiare: è costretto ad accettare un lavoro del genere”.
Per di più “l’Italia ha sempre approvato leggi per “sistemare”: la legge Martelli (1990), la Turco-Napolitano (1998) e la Bossi-Fini (2002) ne sono chiari esempi: regolarizzavano solo persone che erano già qui, non dando quindi la possibilità di entrare regolarmente in Italia”, mi spiega Fiorenzo.
Diversa è invece l’esperienza di Kebe, che, per arrivare in Italia via terra, non poteva nemmeno provare a richiederlo in Spagna e Francia: “in seguito alla legge di Dublino – precisa Fiorenzo – una volta effettuato il riconoscimento ed aver ottenuto protezione (e quindi il permesso di soggiorno) presso un determinato paese, l’immigrato non può più cambiare residenza, ossia non può andare a vivere in un altro paese”. Ecco che quindi è quasi stato costretto a rimanere un migrante irregolare per anni, sempre con la paura che potessero rimpatriarlo.
I migranti si trovano dunque a dover fronteggiare un muro, non fisico come quello eretto da Orban nel 2015 al confine tra Ungheria e Serbia, ma virtuale, i cui mattoni sono leggi, burocrazia e lingua, legati assieme da una malta potentissima: il razzismo.
Hanno però elaborato un piano per demolirlo: restare coesi, solidali gli uni con gli altri.
Come affermato da Tamara e poi testimoniato da Stephan, “quando ad uno di noi viene proposto un lavoro che non può accettare magari perché il luogo è troppo distante e quindi irraggiungibile, se questo conosce un “fratello” che potrebbe invece essere disponibile, facciamo il suo nome e forniamo un suo contatto.
Questo perché abbiamo capito che in Italia se non conosci nessuno non hai nessuna possibilità, soprattutto noi Sub-Sahariani: abbiamo bisogno di legami. Di solito troviamo lavoro in questo modo al 65% (non è un dato empirico)”.
Questa solidarietà “non retribuita” fa riflettere tanto sulle differenze culturali tra le grandi potenze, come Europa e USA, e l’Africa: mentre i primi sono ormai pericolosamente individualisti e pronti a schiacciare chiunque pur di affermarsi, gli altri porgono la mano a chi sta affogando.
Non potrei però concludere senza cedere alla tentazione di analizzare qualche dato.
Nel 2020, secondo money.it, si è stimato un investimento di circa 2.1 miliardi di euro per trasporto, salvataggio, centri di accoglienza, stipendi del personale, servizi di prima assistenza per i migranti, protezione e formazione.
Ad occhio può sembrare una cifra enorme. Ma, prima di iniziare a sbraitare, studiamo un altro paio di dati.
Secondo un video pubblicato da Corriere tv, nel 2019 i disoccupati italiani erano 2.4 milioni, mentre gli occupati stranieri, 2.5. Si potrebbe pensare dunque che gli immigrati (regolari) ci rubino il lavoro: a smentirlo è l’ISTAT che attesta come la maggior parte degli immigrati lavori prevalentemente in settori quali l’agricoltura, cura e assistenza e manifattura. Settori poco occupati dagli italiani.
Inoltre, sempre secondo Corriere tv, gli occupati stranieri (il 10.6% della popolazione) produce il 9% del PIL italiano, pari a ben 140 miliardi. In matematica 2.1 è un numero ben più piccolo di 140.
Secondo l’economia, invece, per investimento si intende rischiare una certa somma di denaro per ricavarne una ben più alta: obiettivo centrato? Credo di sì.
Senza dimenticare un ultimo studio, effettuato sempre dall’ISTAT: nel 2020 si è stimato un numero di circa 600.000 immigrati irregolari impiegati nei settori dell’agricoltura, dell’assistenza, della logistica e dell’edilizia. Se questi fossero regolarizzati, porterebbero circa 1.2 miliardi in più nelle tasche dello Stato.
Oltre a portare beneficio all’economia del Paese, gli immigrati ci servono per combattere quello che è definito come “inverno demografico”: ad oggi si ha un rapporto di tre lavoratori ogni due anziani. Tuttavia si pensa che entro il 2050 tale rapporto arriverà ad 1:1: “not stonks”, diremmo noi.
“Stephan, il suo sogno oggi, invece, quale sarebbe?”
“Il mio sogno è che gli immigrati vengano riconosciuti come delle risorse”.